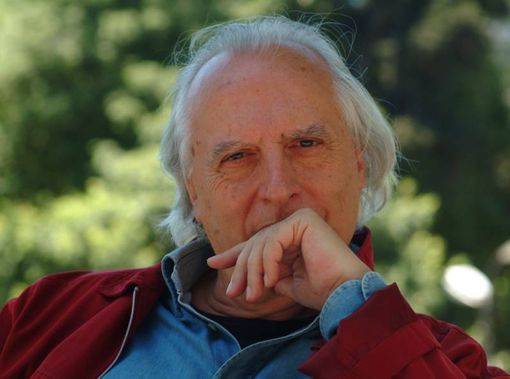
Caro Jorge Luis, ti mando questa mail che vagherà randagia nel cyber-spazio, perché le ombre e l’aldilà non hanno un indirizzo elettronico. È che volevo parlare con te, proprio con te, vecchio maestro di solitudini, di ombre, e di metafore. Nei momenti più bui, e non c’è dubbio che questo lo sia per noi umani sul pianeta Terra, si chiede consolazione alla Poesia. Consolazione, questa parola che i plebei dello spirito hanno cancellato dal vocabolario della letteratura, e di cui invece abbiamo ancora tanto bisogno. Ti confesso che sono ricorso a te, a un tuo sonetto solenne, araldico, appena tornato a casa il giorno lontano che morì mio padre. Lessi i tuoi versi, dove parlavi della morte del tuo genitore, e capii come il mio dolore fosse un filo di una trama di dolori più vasta, connaturata al nostro destino di creature umane. Poco tempo fa, alla morte di mia madre, no, non ti ho chiesto niente: la pena andava al di là di ogni possibile consolazione. Vedo ora la tua immagine, già vecchio e appoggiato a un bastone, di fianco a tua madre, Leonor Acevedo de Borges. Tu devi averlo saputo bene: la perdita della madre, per chi è stato così a lungo figlio, rende «tenebroso, vedovo, inconsolato» come il Principe d’Aquitania dalla torre abolita di cui scrive Gérard de Nerval. Ma oggi mi rivolgo di nuovo a te per chiedere una tregua all’angoscia che mi attanaglia. Sono chiuso in casa, murato, inchiodato alla mia sedia: che è girevole, e mi consente così quasi il mio unico spostamento. Fuori, l’aria è primaverile, ma è come se una cenere appena visibile la traversasse a volo. L’epidemia impera, sovrana assoluta, delle nostre vite. La possibilità di contagio rende sospettosi, egoisti, precari, malinconici. Combattiamo contro un nemico, ma non c’è un fronte, non scorre sangue, non possiamo compiere atti d’eroismo come i gauchos e i guerrieri che tu amavi. L’unico eroismo è quello dei medici e degli infermieri, quello della abnegazione e della pietà. Perché il virus è invisibile, viaggia veloce come un fulmine, ci segue per insinuarsi tra le nostre bocche e le nostre mani, senza che noi ce ne possiamo accorgere. Così ho pensato a te, e ai boscaioli del Wisconsin e del Minnesota. Alla loro strana mitologia che tu non so come hai conosciuto, o inventato di sana pianta. I boscaioli del Wisconsin e del Minnesota favoleggiano di molti animali fantastici: tra questi, il più insidioso è l’Hidebehind. Sanno che alle spalle di ognuno di loro c’è un Hidebehind. Ma non sanno assolutamente come sia fatto, se abbia corna, zanne, zoccoli, niente. Nessuno l’ha mai visto. Nessuno sa come attacca l’uomo. Ma i boscaioli vivono, convivono con la paura dell’Hidebehind. Non lo vedono, non lo sentono, ma sanno che c’è, pronto ad aggredire e a uccidere. Ora, in questi giorni di tenebra, sento di avere anch’io alle mie spalle un Hidebehind silenzioso e del tutto impercettibile. Non è il Mister Hide che trasforma in malvagio assassino il dottor Jekill. Ricordo Mario Soldati, che condivideva con te l’amore per Stevenson, inseguirmi nella biblioteca al secondo piano della sua villa di Tellaro urlando: “Si pronuncia “Jikill” …”. Jekill (comunque si pronunci) e Hide sono due facce di noi stessi, le figure della ineliminabile contraddittorietà dell’essere uomini. Ma l’Hidebehind è fuori di noi, e sta alle nostre spalle, malvagia parodia di un angelo custode, con la precisa, fatale volontà di uccidere. Assomiglia a questo virus che viene da lontano ma che ormai è qui tra di noi. Io passeggiavo a febbraio per le vie di Milano, i miei itinerari prediletti, partendo dal mio albergo in corso Europa: Corso Vittorio Emanuele, il Duomo, e da lì via Torino, o piazza Cordusio, o via Manzoni, e il virus, come un Hidebehind, mi seguiva di sicuro. Prendevo un caffè tra la folla che popola Starbucks, cenavo nella allegra confusione del Santa Lucia e lui stava lì, sedeva dietro di me. Sono tornato a casa in Riviera e ho trovato che la presenza del mare, del mio amato mare, non lo inibiva. C’era, il virus, c’era il contagio, anche tra i giardini, tra le palme, almeno quelle che hanno resistito alla loro epidemia, all’attacco del punteruolo rosso anche lui venuto dalla Cina, che ne ha ridotte tante a mozziconi di legno marcito. Come il nuovo virus vorrebbe fare di noi. Così mi sono messo in auto-quarantena. Niente colazione in pasticceria, a scegliere nelle vetrinette tra decine di dolci deliziosi, niente passeggiate a filo delle onde, niente scappate in Francia, niente, neppure più il mio fidato ristorante, dove sono solito mangiare ravioli o linguine ai frutti di mare. Tutto è chiuso. E io sono qui in casa, inchiodato alla sedia tra i miei due tavoli di lavoro, o rovesciato su un divano sotto una vetrata da cui vedo una larga fascia di cielo, ad ascoltare Radio Swiss Jazz. Lavo le mani con terribile frenesia, manco le avessi sporche dei delitti di Lady Macbeth. Telefono agli amici. Prego il Signore dell’Universo. Parlo con i ritratti di mio padre e mia madre. Scrivo a te. Così spero che il virus non passi attraverso la porta blindata e i muri. Che l’Hidebehind mi lasci in pace. Tu cosa ne dici? Che altro nome daresti a questo nemico silenzioso, vile, avverso al sogno? Quale sacrificio dovremo fare per fermarlo? All’inizio dell’Iliade, Calcante suggerisce un sacrificio ai Greci per fermare Apollo che li decima con frecce portatrici di una epidemia mortale, puntando prima muli e cani, e poi gli uomini. Certi credono che sia possibile esorcizzare il male del virus, l’isolamento in cui ci costringe, con una risposta di fiducia, di canto, di condivisione. Mi scrive una giovanissima amica, una che da poco ha letto il tuo Elogio dell’ombra, che Napoli, la sua città sempre in bilico tra vita e morte sotto la minaccia giudicante e silenziosa del Vesuvio, risponde con il suo misto di giocosità e fatalismo: e fa impazzare sui balconi delle sue case un teatro variopinto in cui i reclusi intessono un dialogo aereo con gli altri reclusi, fatto di musiche e di canzoni. Beati loro. Io sul mio terrazzo non ci esco neppure, tanto temo quest’aria avvelenata. E poi dialogherei con chi? Forse con un abete gigante, con l’albero del pepe dalla gran chioma che i giardinieri sfrondano e potano invano. Me ne sto chiuso anche in me stesso, cieco, con il mio Hidebehind alle spalle, che non vedo, che non so cosa e come è, ma c’è, ed è inutile girarsi di scatto per sorprenderlo, tu me lo hai insegnato. Hai scritto di aver commesso il più grave peccato: quello di non essere stato felice. Io ne ho commesso uno ancora più grave. Io lo sono stato, felice. Ho puntato sulla gioia, in questa impazzita roulette della nostra umana esistenza. Ho creduto e propagato sempre la fiducia nella primavera. Nell’Amore, nella Poesia. E ora? E se il virus non viene sconfitto? Se come lo Hidebehind continuerà a seguirci alle spalle, pronto a ghermirci? Tutto si fa più difficile. Ma io continuo a credere nel potere dell’anima, del vento e delle onde. E ti saluto, ombra, guardiano dei libri, custode della Grande Biblioteca dell’Universo, che mi dai il coraggio di credere ancora nella Letteratura. P.S.
Buenos Aires è bellissima, e io, quando si poteva ancora viaggiare, ho a lungo cercato i caffè dove tu ti sedevi e il linguaggio dei simboli, delle metafore, delle allegorie pioveva su di te, e la tua cecità diventava luce.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.
