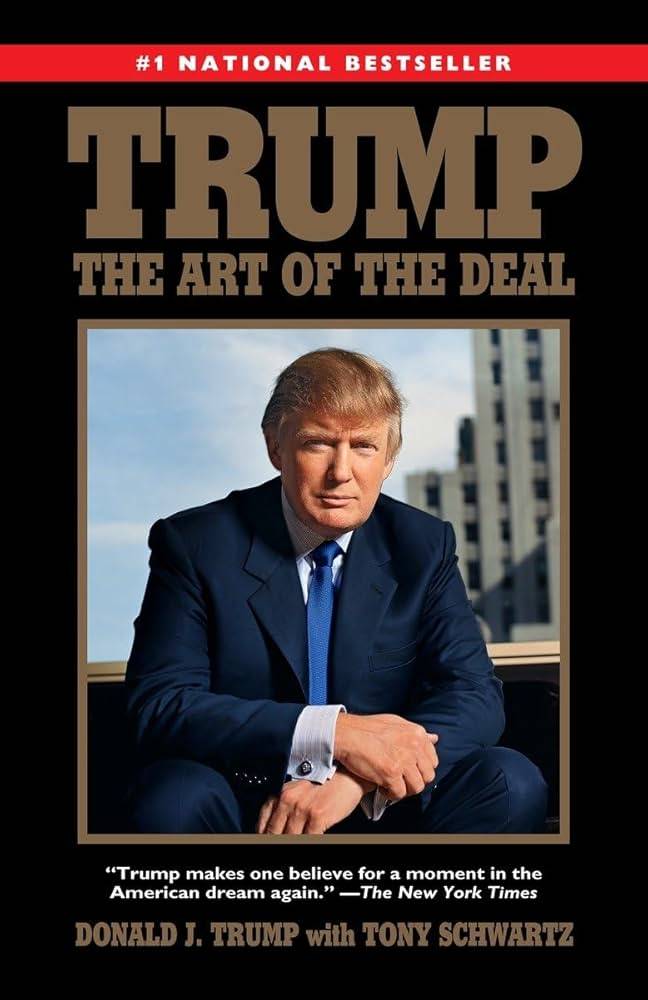
Manhattan, fine anni Ottanta. Quando nel 1987 esce The Art of the Deal, Donald Trump non è ancora l’icona MAGA che diventerà decenni dopo, ma è già una figura ben nota nel mondo immobiliare e nei media americani. Il libro, firmato insieme al giornalista Tony Schwartz (che in seguito ne rivendicherà la paternità quasi esclusiva), si presenta come un’autobiografia imprenditoriale, ma in realtà è soprattutto un’operazione di costruzione dell’immagine: quella del tycoon infallibile, spregiudicato e vincente.
Chi è il Trump di fine anni Ottanta
Sul piano personale, Trump è all’apice della sua ascesa. Dopo il successo con il Grand Hyatt Hotel e con la Trump Tower (inaugurata nel 1983 sulla Fifth Avenue), si è lanciato nel business dei casinò ad Atlantic City. È onnipresente sui media, coltiva con cura la propria esposizione pubblica e comincia a costruire un marchio attorno al suo nome, sinonimo di lusso, potere e successo. Nonostante l’apparente prosperità, sta iniziando ad accumulare debiti significativi che emergeranno nei primi anni Novanta, ma al tempo del libro, l’immagine che trasmette è quella di un vincente assoluto. Un monumento al predestinato americano, anche se l’accusa di essere un “robber baron” è sempre dietro l’angolo, in un’America ancora profondamente puritana nel pieno del risveglio evnagelico. Cinque anni dopo, però, compare nell’iconico Mamma ho riperso l’aereo, una testimonianza “pop” del mito trumpiano.
Il contesto è quello dell’America reaganiana: deregulation, culto del libero mercato e trionfo dell’individualismo. È l’epoca di Wall Street e del “Greed is good”, dove il successo economico è l’unica misura del valore personale. In questo clima, Trump incarna perfettamente lo spirito del tempo. New York, uscita da una crisi profonda, è tornata a essere un terreno fertile per gli speculatori immobiliari, e The Donald ne è uno degli attori più visibili e controversi.
Perché The art of the deal era già un manifesto
The Art of the Deal diventa così molto più di un manuale di business for dummies: è una dichiarazione di intenti, una piattaforma narrativa da cui Trump lancia la propria visione del mondo. Un mix tra von Clausewitz, Sun Tzu, la teoria dei Giochi e…Trump. Una visione basata sullo scontro, sul vantaggio negoziale, sulla costruzione del mito personale. Chi legge quel libro oggi, con il senno di poi, potrà trovarci non tanto strategie economiche, quanto la premessa ideologica del Trump che, trent’anni dopo, avrebbe portato quello stesso spirito nel cuore della Casa Bianca. Che l’abbia scritto lui o meno, the Art of deal racconta di un uomo incredibilmente rimasto identico a se stesso nel concepire la negoziazione alle sue regole: "Il rischio è peggiorare una situazione già difficile, e certamente non consiglio questo approccio a tutti. Ma la mia esperienza è che, se stai lottando per qualcosa in cui credi — anche se questo significa alienare alcune persone lungo il percorso — di solito le cose finiscono per andare per il meglio, tuona Trump nei primi capitoli della sua Bibbia.
Chi legge oggi il libro, non trova un programma politico in senso stretto. Non potrebbe. Eppure, riga dopo riga, ci si imbatte in una visione del mondo che anticipa con inquietante coerenza la postura muscolare adottata decenni dopo dall’inquilino della Casa Bianca, dai dazi punitivi contro la Cina fino al cinismo nei confronti delle istituzioni multilaterali. La diplomazia di oggi appare dunque la prosecuzione del business con altri mezzi-per parafrasare l’antica definizione- e che ogni relazione internazionale vada trattata come un affare da chiudere a proprio vantaggio — o da rompere clamorosamente.
"Pensa grande, alza la posta, genera il caos"
Nel mondo descritto da Trump, non esistono alleati stabili ma solo avversari da piegare. Ogni trattativa è un gioco a somma zero, in cui la vittoria non è un compromesso elegante ma uno show finale con un solo vincitore — lui. La parola “lealtà” scompare, sostituita da “leva”: chi controlla ciò che l’altro desidera ha il potere, e il potere va esercitato senza esitazioni. Dice Trump: "La cosa peggiore che puoi fare in una trattativa è sembrare disperato di concluderla. Questo fa sentire l’altro come se avesse fiutato sangue — e a quel punto sei finito. La cosa migliore che puoi fare è trattare da una posizione di forza, e la leva è la forza più grande che tu possa avere". È una logica da tavolo da gioco, più che da boardroom, ma funziona per chi vuole sovvertire le regole. E così, mentre gli esperti di geopolitica si lambiccavano il cervello sul significato dei post notturni di Trump o sull’ennesimo strappo a un trattato internazionale, la vera chiave di lettura era già lì, nero su bianco, nel cuore degli anni Ottanta e in quelle 372 pagine. Capitolo, dopo capitolo, al di là di più di qualche digressione narcisistica (sulla sua statura, ad esempio) Trump spiegava che per vincere serve pensare in grande, alzare subito la posta e non temere il caos: l’importante è confondere l’avversario, tenere tutti in bilico, e dominare la scena.
Anche la copertura mediatica diventa parte della strategia — meglio se polarizzante, meglio ancora se scandalosa. Il contenuto passa in secondo piano; ciò che conta è apparire imbattibile. The Art of the Deal non parlava di dazi, certamente, ma ne anticipava perfettamente lo spirito: usare la minaccia economica come bastone, promettere intese come carota, rompere l’equilibrio per crearne uno nuovo — a proprio vantaggio. L’“arte dell’accordo”, come lui la chiama, non è mediazione. È dominazione. Nel cuore di questa visione c’è l’idea che ogni trattativa debba essere impostata come un confronto tra forze, non tra interessi. Trump non crede nella fiducia reciproca o nella cooperazione. Crede nella pressione, nella costruzione del vantaggio psicologico, nell’uso spregiudicato del tempo, dell’informazione e — soprattutto — dell’incertezza: "Per quanto sia utile enfatizzare gli aspetti positivi, ci sono momenti in cui l’unica scelta è lo scontro. Nella maggior parte dei casi sono molto facile da trattare. Sono molto buono con chi è buono con me. Ma quando le persone mi trattano male o in modo ingiusto o cercano di approfittarsi di me, il mio atteggiamento generale, per tutta la vita, è stato quello di reagire con forza". Sembra quasi di risentire il Trump di oggi che inveisce contro l'Europa, rea di "trattar male gli Stati Uniti".
Essere imprevedibili
L’obiettivo non è creare valore condiviso, ma estrarre valore, anche a costo di rompere il tavolo. Uno dei passaggi più rivelatori è quando afferma che “la chiave è essere imprevedibili”. In altre parole: disorienta il tuo interlocutore, falla fuori dal copione, cambia le carte in tavola all’ultimo secondo. Trump non negozia per trovare equilibrio: negozia per sbilanciare l’altro. E lo fa utilizzando ogni arma retorica e simbolica a sua disposizione — compresa la stampa, che considera un'estensione del suo braccio negoziale. Un'affermazione fatta in prima pagina può valere più di una clausola contrattuale.
Il processo è sempre lo stesso: alzare la posta, generare caos, poi presentarsi come unica via d’uscita. È una logica che ha applicato nel mondo immobiliare ma che ha poi esportato, pari pari, nei rapporti con la Cina, l’Europa, la NATO. Dazi, sanzioni, minacce, annunci roboanti: tutto rientra in una visione in cui la trattativa non serve a costruire ponti, ma a fare pressione. E se l’altro si sente sotto ricatto? Tanto meglio. L'accordo ideale, nel mondo trumpiano, non è quello in cui tutti escono soddisfatti, ma quello in cui lui può salire sul palco e dire: ho vinto, lui ha perso. L’effetto è voluto.
Una logica eminentemente realista, da anni ruggenti: per dirla nella lingua delle Relazioni Internazionali, nel mondo di Trump i realisti vincono, i neorealisti perdono. E ora, con la nuova escalation commerciale, scopriamo che quelle vecchie pagine erano meno un memoir e più un manuale di battaglia. Piaccia o meno, lui l'aveva già scritto.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.
