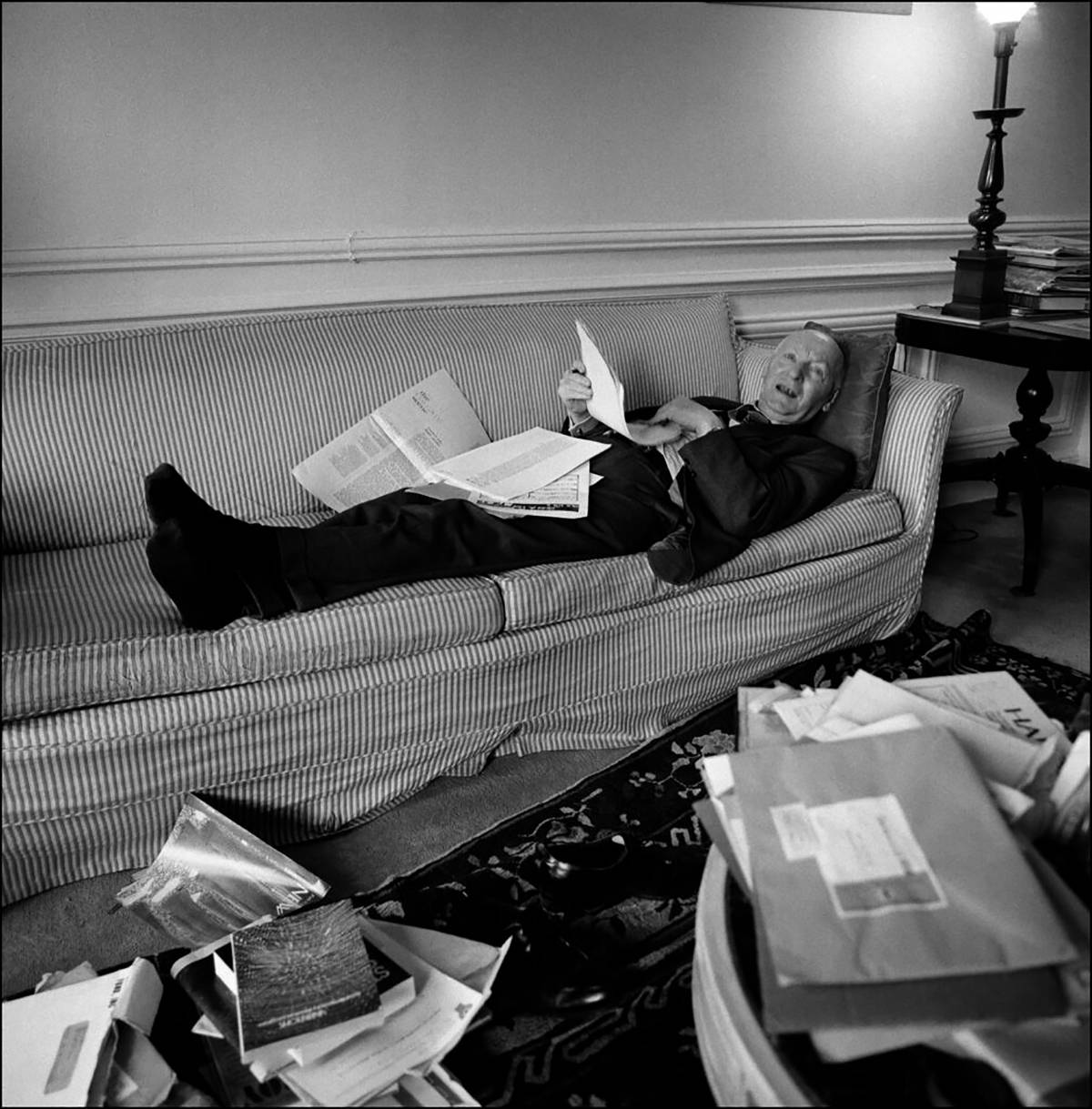
«La candela aveva finito di bruciare. Dalla finestra entrava il chiarore di una luna antelucana, sfrangiata e velata dalla nebbia. A oriente il cielo diventava rosso. Qualcosa c'è mormorò il Rebbe. La guerra tra il Rebbe di Bechev e Dio era giunta al termine». Così termina l'ultimo racconto, Qualcosa c'è, della raccolta Un amico di Kafka di Isaac Bashevis Singer, ripubblicato da Adelphi in una nuova e assai valida traduzione di Katia Bagnoli (pagg. 338, euro 22).
Questi 21 racconti furono in gran parte pubblicati sul Forwerts, il quotidiano yiddish di New York. Proprio per collaborare al giornale Singer si era trasferito in America nel 1935, raggiungendo il fratello Israel, già famoso. Entrambi provenivano da una famiglia devota di pii chassidim: da generazioni gli antenati erano rabbini. Ma i tempi ormai erano in tumultuoso cambiamento. Eppure quella radice ebraica e mistica era fortissima e segnò per tutta la vita Singer che nei suoi romanzi e racconti si confrontò continuamente con quella esperienza che era una ferita profonda che non cicatrizzava.
E proprio l'ultimo racconto costituisce la chiave per entrare nel significato profondo della sua ispirazione. Si narra di Nechemia, un giovane Rebbe (rabbino) che comincia a dubitare, a porsi continue domande: quelle domande per cui l'uomo della modernità non ha risposte definitive. Torturato dai dubbi che gli si palesano come certezze inconfutabili, Nechemia abbandona Bechev, il piccolo paesino, lo shtetl ebraico-polacco, e fugge a Varsavia dove viveva la più numerosa comunità di ebrei fino allo scoppio della Grande Guerra. Tenta di trovare un senso alla sua ricerca, frequenta librerie e biblioteche, ma il buio si fa sempre più fitto e vive nel grande ghetto conoscendo la miseria materiale e morale di un mondo in disfacimento, alla vigilia della sua scomparsa. Il carbonaio, che lo ospita, cui il giovane, disperato, chiede se crede in Dio, gli risponde con l'umile, rozza eppur toccante saggezza del povero: «Come faccio a saperlo? Non sono mai stato in cielo. Qualcosa c'è». Questa è l'estrema certezza, che a mo' di filo rosso unisce i vari racconti, che si dividono, come l'esistenza di Singer, in rievocazioni (le più belle artisticamente e psicologicamente) dell'ebraismo orientale degli shtetl, nonché in raffigurazioni di destini degli ebrei emigrati a New York e in un caso in Argentina, insomma nel Nuovo Mondo, dove loro si trascinano dentro quello vecchio che non li molla e che rappresenta la loro tortura, ma anche la loro estrema ancora di salvezza e di saldezza.
Spesso sono rammemorazioni autobiografiche, come il racconto del figlio che l'autore dell'omonimo racconto rincontra dopo vent'anni quasi come se fosse la prima volta. Le figure dello shtetl riappaiono diverse e sempre uguali, con i medesimi, inconfondibili sguardi di sempre: «tristi e allegri occhi ebraici, antichi quanto la Diaspora». All'insistente domanda sul perché si è ebrei, perché si resta ebrei anche senza fede, la risposta pare paradossale, ma inconfutabile: «Non possiamo non esserlo. Non si può assimilare un popolo intero. Inoltre i goyim non ci vogliono». Un'amara verità che l'ebraismo orientale avrebbe presto sperimentato con lo sterminio nei lager e nei gulag.
L'emigrazione americana significava la salvezza fisica, ma non sempre quella spirituale e intellettuale. Lo scrittore a New York non sa più scrivere, poiché il popolo del libro aveva smarrito il libro: «Avevo perso ogni desiderio di scrivere. Le mie dita divennero fiacche. Le stilografiche mi sabotavano: o spandevano inchiostro o non ne facevano uscire abbastanza. Spesso dicevo l'opposto di quello che intendevo dire, come se mi avesse posseduto un dybbuk letterario». È probabilmente un frammento autobiografico in un momento di crisi, con quelle frequentazioni con esseri umani alla deriva, spaesati, perduti, con il numero tatuato sul braccio, fantasmi a loro stessi, perseguitati dagli spettri di uno ieri sempre presente, come quando una donna racconta di aver visto, in una notte insonne, Hitler e suoi gerarchi nella tavola calda a Broadway. È come se il tempo intimo dei superstiti, dei sopravvissuti si fosse fermato allora, ad Auschwitz. Un tempo che non passa insieme alla domanda sulla causa: perché lo sterminio? Domanda che non conosce risposta.
Il racconto più famoso - uno di quelli che hanno fatto meritare nel 1978 a Singer il Premio Nobel per la letteratura - che dà il titolo alla raccolta, si svolge agli inizi degli anni Trenta al Circolo degli Scrittori yiddish di Varsavia, assiduamente frequentato dal giovane Singer il quale vi incontra Jacques Kohn, l'«amico di Kafka». In realtà nel 1911 Kafka aveva frequentato con crescente entusiasmo una compagnia di attori yiddish polacchi che nel Café Savoy di Praga mettevano in scena drammi del teatro yiddish, allora ancora fiorente. Nei diari lo scrittore parla - per esempio il 22 ottobre 1911 - con commozione di quel gruppo di attori: «La compassione che proviamo per questi attori così bravi che non guadagnano niente e, in genere non conseguono neanche di gran lunga la gratitudine e la fama che meritano, è a rigore soltanto la compassione per la triste sorte di molte nobili iniziative, soprattutto le nostre».
Molto kafkiano: solo che l'attore si chiamava Isak Löwy. Altri particolari corrispondono alla realtà: Kafka si era veramente innamorato di una attrice, la signora Tschissik.
Un sentimento consegnato ai diari perché, come afferma a Singer Jacques Kohn, alias Isak Löwy: «Kafka era timido, timido come uno studente di yeshivah», ovvero della scuola religiosa ebraica. Vero o non vero, un grande racconto per capire Singer e anche Kafka.
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.
